di Alain Bihr
Il libro di K. Saito, La nature contre le capital. L’écologie de Marx dans sa critique inachevée du capital (La natura contro il capitale. L’ecologia di Marx nella sua critica incompiuta del capitale), appena uscito per le edizioni Syllepse e Page Deux (in traduzione dall’originale in lingua tedesca delle Edizioni Campus Verlag, 2016), è un libro importante. Perché consente di fare piena luce su quello che fino ad una ventina d’anni fa era considerato un ossimoro: appunto l’ecologia di Marx. Non si contano, infatti, le critiche rivolte al Moro per avere assorbito dal pensiero borghese un vero e proprio “feticismo delle forze produttive” e del loro sviluppo, per aver dato prova di un “prometeismo antropocentrico” contenente uno sguardo strumentale e un’attitudine dominatrice nei confronti della natura. Accuse che non sono del tutto prive di fondamento se riferite a singoli aspetti o momenti dell’indagine di Marx, ma risultano alla fine contraddette e smentite in modo decisivo dal filo rosso che Saito (dopo Burkett, Foster ed altri) ricostruisce con grande rigore, a partire dai Manoscritti economico-filosofici del 1844 per arrivare all’enorme massa dei “cahiers de lecture de Marx consacrés aux sciences de la nature” (biologia, chimica, botanica, geologia, mineralogia, etc.) redatti in buona parte negli ultimi dieci-quindici anni della sua vita e resi finalmente pubblici grazie alla nuova edizione delle opere complete di Marx ed Engels in corso (la cd. MEGA-2). Ne viene fuori la dimostrazione che la critica ecologica di Marx, progressivamente affinata sulla base dei contributi di Liebig, Fraas e di altri studiosi della natura, in quanto comporta l’analisi delle correlazioni tra le forme economico-sociali e il mondo materiale concreto, è parte integrante della sua critica dell’economia politica e del modo di produzione capitalistico. E che tale critica mette capo alla convinzione che la natura nel suo insieme, come mondo fisico-materiale, oppone resistenza al capitale, alla immodificabile pretesa del capitale di accumulare indefinitamente profitti saccheggiando al tempo stesso il lavoro vivo e la natura non umana. Dunque, non solo il capitale contro la natura, ma anche la natura contro il capitale – da qui il titolo del libro. Ne stavamo apprestando una recensione, quando sul sito di Alencontre è comparsa questa recensione ragionata di Alain Bihr, che volentieri abbiamo tradotto e ripreso: L’écologie de Marx à la lumière de la MEGA 2 (I). Inutile sottolineare le implicazioni di questo lavoro per la situazione odierna. (da pungolorosso.wordpress.com)
***
Da una trentina d’anni si moltiplicano gli studi volti a valutare la portata dell’opera di Marx (oltre a quella di Engels, ad essa strettamente legata) alla luce del tema e delle problematiche ecologiche. Pungolati dalla crescente consapevolezza della portata della catastrofe ecologica in cui siamo immersi e dell’urgenza che c’è di affrontarla, tali studi hanno cercato di determinare se e in che misura il lavoro di Marx possa far luce sugli annessi e i connessi di questo disastro e aiutare a formulare risposte appropriate per progettare l’uscita da esso.
Due tendenze sono emerse rapidamente a questo riguardo. Per alcuni, non solo l’opera di Marx non avrebbe nulla da insegnarci su questo terreno, ma qualsiasi pensiero che sia seriamente interessato a prendere di petto questa tematica e problematica dovrebbe starne alla larga per evitare di esserne deviato, tanto l’opera di Marx sarebbe rimasta, in definitiva, prigioniera di un prometeismo teso ad esaltare in maniera irriflessiva la crescita delle forze produttive, in quanto una delle condizioni sine qua non del socialismo. Il pensiero di Marx avrebbe così aperto la strada alla cecità che il movimento socialista (sia nella sua versione socialdemocratica sia in quella declinata dal cosiddetto “socialismo reale”) ha mostrato nei confronti della dinamica generatrice del disastro ecologico in corso, avendo quindi una specifica quota di responsabilità in quest’ultimo [1]. Per altri, invece, l’opera di Marx, correttamente valutata o rivalutata, non solo testimonierebbe una sicura sensibilità ecologica, ma farebbe emergere prospettive originali sia per quanto riguarda la comprensione teorica delle radici della catastrofe ecologica, sia per la formulazione di proposte politiche per cercare di affrontarle [2].
Kohei Saïto segue apertamente questo secondo percorso, che è oggi già ben tracciato [3]. La sua originalità risiede, però, prima di tutto nelle fonti che utilizza. Egli non si accontenta, infatti, di riesaminare ancora una volta i testi canonici di Marx. Basandosi su tutti i volumi della MEGA 2 già pubblicati [4], estende notevolmente il corpus di riferimento ad alcuni testi inediti di Marx, sia che si tratti della cospicua mole di manoscritti che ha preparato o accompagnato l’elaborazione della sua critica dell’economia politica, lasciata alla fine in sospeso con Il Capitale, sia che si tratti dell’ancor maggiore numero di quaderni di appunti e di note a margine apposte da Marx sulle opere presenti nella sua biblioteca e ivi conservate. I nuovi documenti così inseriti nel dossier consentono di seguire meglio l’evoluzione del pensiero di Marx sulle questioni relative all’ecologia. Fanno anche maggiore luce sul modo in cui operava Marx e spiegano infine perché, lungi dall’averci lasciato in eredità un monumento teorico concluso, il suo lavoro ci ha lasciato in eredità un vero e proprio cantiere, in tutti i sensi. E sta a noi continuare a lavorarci.
Le prime intuizioni fondative
A partire dall’autunno del 1843, dopo essersi stabilito a Parigi, per approfondire la critica della società civile borghese a cui fu condotto sia dalla sua attività di giornalista all’interno della Rheinische Zeitung sia dalla sua rilettura della filosofia del diritto di Hegel, Marx intraprende la lettura dei principali economisti (a partire da Adam Smith e David Ricardo), inaugurando così una ricerca che lo occuperà per il resto della sua vita. Lo testimonia la serie di taccuini e riflessioni che sono conosciuti con il nome di Manoscritti del 1844 o di Manoscritti economico-filosofici.
Questi manoscritti sono di grande densità teorica. Marx vi moltiplica formule brillanti, alcune di esse non molto chiare, che risentono ancora, nel loro conio, dell’eredità hegeliana, rivisitata attraverso il prisma giovane-hegeliano, in particolare quello di Ludwig Feuerbach. Vi troviamo anzitutto una concezione originale del rapporto tra uomo e natura, destinata a informare tutte le sue ulteriori elaborazioni su questo argomento. La natura vi è infatti definita come “il corpo non organico” dell’umanità.
“L’universalità dell’uomo appare praticamente proprio in querlla universalità, che fa della intera natura il corpo inorganico dell’uomo, sia perché essa 1) è un mezzo immediato di sussistenza, sia perché 2) è la materia, l’oggetto e lo strumento della sua attività vitale. La natura è il corpo inorganico dell’uomo, precisamente la natura in quanto non è essa stessa corpo umano». [5]
Ma fin dall’inizio Marx sottolinea la specificità dell’unità dell’umanità e della natura che è costituita dal lavoro. Perché è solo attraverso la mediazione del lavoro, della trasformazione della natura che quest’ultima realizza, che l’umanità può attingere da essa la sostanza della sua esistenza. All’interno di questi Manoscritti, sempre sotto l’influenza dell’hegelismo, Marx riconduce questa specificità innanzitutto al carattere cosciente, quindi volontario, riflessivo, finalizzato del lavoro, laddove invece la possibile attività trasformatrice della natura esercitata dall’animale resta prigioniera del suo istinto e, di conseguenza, della ristretta cerchia dei suoi bisogni. Ciò introduce una seconda differenza essenziale: mentre il lavoro animale è limitato a questi bisogni e alla sua particolare ecosfera, il lavoro dell’uomo tende a diventare universale (estende di continuo il suo campo nella misura in cui genera costantemente nuovi bisogni):
“L’attività vitale cosciente dell’uomo distingue l’uomo immediatamente dall’attività vitale dell’animale […]. L’animale costruisce soltanto secondo la misura e il bisogno della specie, a cui appartiene, mentre l’uomo sa produrre secondo la misura di ogni specie e sa ovunque predisporre la misura inerente a quel determinato oggetto; quindi l’uomo costruisce anche secondo le leggi della bellezza». [6]
Su questa base, Marx rimprovera fondamentalmente al capitalismo di aver rotto questa unità fondamentale, costitutiva tra l’umanità e il suo corpo inorganico, rendendo improvvisamente la prima estranea al secondo e viceversa, ed introducendo così una dimensione di alienazione nei loro rapporti. Quest’ultima dimensione (l’alienazione) affonda le sue radici nell’espropriazione dei produttori: la loro separazione de facto e de jure dai loro mezzi di produzione, dalle condizioni oggettive di produzione dei loro mezzi di consumo, dalle condizioni materiali della loro sussistenza, la principale delle quali è la terra.
Questa tesi emerge quando Marx si propone di esplicitare nei suoi taccuini la differenza tra proprietà fondiaria feudale e proprietà fondiaria capitalista – un passaggio sul quale Saïto giustamente richiama l’attenzione (pagg. 33-44), rilevando che il più delle volte è sfuggito ai commentatori di questi manoscritti [7].
Nell’ambito della proprietà feudale, contadini e contadini furono ridotti in schiavitù: ridotti allo stato di servi. Ora, la servitù è definita da un doppio legame: il legame del servo al fondo di cui è parte integrante (e come tale può essere venduto con il fondo): «il servo è accessorio della terra» (egli è adscriptus glebae, assegnato alla terra, secondo il diritto feudale); il legame del servo al signore di questo fondo, il feudatario, al quale lo lega un rapporto di fedeltà, di dipendenza personale; che conferisce al dominio e allo sfruttamento feudale un fascino gemütlich (confortevole), dice Marx [8], al di là del suo carattere di brutale rapporto di forza. Il punto importante qui è che il produttore diretto (il servo) rimane legato alla terra come mezzo di produzione; nella servitù, la terra rimane “il corpo inorganico” del produttore, così come lo è, del resto, per il suo stesso proprietario, il signore, il padrone, che non appartiene al suo fondo meno dei suoi servi: ciò che la sua particella di terra significa fondamentalmente, è che egli è barone, conte, marchese, duca, principe di…, quando non è direttamente denominato dal nome del dominio: quindi dei Valois, Guise, Bourbon, Habsbourg, Lancaster, York, ecc.
Questo è proprio ciò che manca totalmente al lavoratore salariato, che egli sia agricolo o meno, che è, per definizione, un “lavoratore libero”. E anche doppiamente “libero”: liberato da ogni legame di dipendenza personale e comunitaria e liberato da ogni mezzo di produzione proprio. La sua unica proprietà resta la sua stessa persona, le sue facoltà personali che costituiscono la sua forza (capacita) di lavoro, di cui può invece disporre interamente a suo piacimento: egli è a questo titolo un soggetto di diritto privato. Ma improvvisamente, per ottenere i suoi mezzi di sussistenza, non ha altra possibilità che mettere in vendita questa forza lavoro, sperando che qualcuno la compri da lui (in cambio di un salario), al servizio del quale o della quale dovrà porsi, in linea generale per valorizzare un capitale, producendo più valore del valore della sua forza lavoro. In altre parole, a differenza del servo della gleba, le sue condizioni di esistenza non sono in alcun modo garantite dai rapporti di produzione entro i quali egli opera, che possono contarlo perfettamente, e trattarlo, come un soprannumerario “inutile al mondo”.
Sotto il regime capitalista, quindi, il produttore non ha più un rapporto diretto con la terra come mezzo di produzione e riproduzione della propria esistenza, come “corpo inorganico”, anche quando si tratta di un lavoratore agricolo. In quest’ultimo caso, egli produce i suoi mezzi di sussistenza solo accidentalmente e marginalmente: la terra non è altro che il mezzo per aggiungere valore a un capitale investito in agricoltura. Viceversa, mentre questo mezzo di produzione che è la terra è stato separato da colui che la lavora, si separa anche da lui e può così diventare pienamente una merce, essere comprata e venduta per tutti i fini possibili, come mezzo di produzione oppure come mezzo di consumo (oggetto di godimento per il suo proprietario o possessore).
Tutti questi temi e tesi costituiscono lo sfondo teorico che continuerà ad alimentare il pensiero di Marx, ben oltre i Manoscritti del 1844. Li ritroviamo anche nelle sue opere mature che svilupperanno la sua critica dell’economia politica. Ad esempio nel seguente brano dei famosi Grundrisse (1857-1858) che sembra ripetere i precedenti parola per parola:
“Non è l’unità degli uomini viventi e attivi con le condizioni naturali, inorganiche del loro ricambio materiale con la natura, e per conseguenza la loro appropriazione della natura, che ha bisogno di una spiegazione o che è il risultato di un processo storico, ma la separazione di queste condizioni inorganiche dell’esistenza umana da questa esistenza attiva, una separazione che si attua pienamente soltanto nel rapporto tra lavoro salariato e capitale. Nel rapporto di schiavitù e di servitù della gleba, questa separazione non avviene; bensì una parte della società viene essa stessa trattata dall’altra come mera condizione inorganica e naturale della propria riproduzione». [9] Anche qui, la rottura dell’unità costitutiva tra umanità e natura, cioè la separazione tra l’essere umano, la natura soggettivata, e il suo corpo inorganico, la condizione oggettiva della sua esistenza e della sua attività lavorativa, è data da Marx come la caratteristica principale dell’universo capitalista, la condizione stessa della formazione del capitale che gli serve da base e da cornicer.
Marx di fronte a Liebig
Tuttavia, Marx non si accontenterà di ripetere queste formule fino alla nausea. Al contrario, cercherà di verificarle confrontandole con le scienze positive del suo tempo. Questo gli permetterà di arricchirle di nuove determinazioni, ma lo costringerà anche a qualificarle e a rettificarle in parte. Tutto questo lavoro teorico marxista è meticolosamente investigato ed espresso da Saito.
Il passo già citato dei Grundrisse impiega così una nuova nozione, ancora sconosciuta al Marx dei Manoscritti del 1844, quella dello scambio di sostanza tra uomo e natura, che letteralmente traduce il tedesco Stoffwechsel. Altri traduttori, incluso Billy, hanno optato per il termine metabolismo, che è senza dubbio molto più fedele alle origini del termine.
Il concetto di metabolismo è mutuato dalla biologia, per l’esattezza dalla fisiologia. All’interno di quest’ultima designa, da un lato, il sistema di scambi di sostanze diverse tra tutte le parti di un organismo vivente (pianta, animale o essere umano), scambi mediante i quali l’organismo vivente si rigenera di continuo conservando il proprio ordine interno (questo è il metabolismo interno); dall’altro, indica gli scambi che ogni organismo vivente è tenuto ad effettuare con il suo ambiente di vita (il suo biotopo), per mezzo dei quali preleva le sostanze necessarie al suo funzionamento di organismo vivente ed espelle i rifiuti derivanti da questo funzionamento (questo è il metabolismo esterno). Metabolismo esterno e metabolismo interno, quindi, sono strettamente legati: il primo fornisce al secondo sostanze che, direttamente o dopo la loro trasformazione, vengono assimilate dall’organismo per mantenersi in vita, provvedendo all’eliminazione dei suoi sottoprodotti (rifiuti).
Il concetto sembra essere stato introdotto in fisiologia negli anni 1800-1810, prima di diventare di uso comune negli anni quaranta dell’Ottocento, in particolare in seguito alla pubblicazione di due grandi opere da parte del chimico tedesco Justus von Liebig (1803-1873): Die Chemie in ihrer Anwendung an Agriculturchemie und Physiologie (La chimica applicata all’agricoltura e alla fisiologia) (1840) e Die Chemie in ihrer Anwendung auf Physiologie und Pathologie (La chimica applicata alla fisiologia e alla patologia) (1842), che posero le basi per la chimica organica e la biochimica.
Basandosi sui taccuini e le letture di Marx dell’inizio del suo periodo londinese, Saïto (pagine 71-80) accerta che è dall’inizio del 1851, e precisamente dalla lettura del manoscritto di Roland Daniels, medico di Colonia, membro come lui della Lega dei comunisti, Mikrocosmos. Entwurf einer physiologischen Anthropologie (Microcosmos. Saggio di antropologia fisiologica), un manoscritto da lui ricevuto per un parere critico, che Marx fa uso del concetto di metabolismo. Ed è proprio questa lettura che lo porta ad interessarsi all’opera e alle pubblicazioni di Liebig nei mesi successivi, durante i quali legge e annota la quarta edizione di Die Chemie in ihrer Anwendung an Agriculturchemie und Physiologie (1842). A partire da quel momento il concetto di metabolismo diventerà parte integrante del suo apparato categoriale, come testimoniano i Grundrisse in cui il termine è usato da Marx una ventina di volte per designare sia gli scambi materiali interni alla società (metabolismo sociale), sia gli scambi materiali interni alla natura (metabolismo naturale), sia infine gli scambi materiali tra gli uomini e la natura (Saïto: 80-85). Ed è proprio quest’ultimo metabolismo che il capitale viene a sconvolgere, rompendo l’unità immediata tra l’umanità e il suo corpo inorganico.
Liebig non è qui citato, tuttavia, il che suggerisce che, pur avendo in parte raccolto il suo contributo, Marx non gli attribuisce ancora l’importanza che assumerà per lui in seguito. Diversi indici attestano infatti che Marx riprese a leggere Liebig, più precisamente Die Chemie… pubblicato nel 1862 (Saïto: 176-177 e 181-184), tra la metà del 1863 e la metà del 1865 mentre scriveva una prima versione del Capitale, senza dubbio in connessione con la sua teoria della rendita fondiaria [10]. E che, questa volta, tale (ri)lettura avrà un impatto decisivo. Cerchiamo di determinare cosa ne ritenne Marx.
Liebig ha posto le basi per la biochimica della crescita vegetale dimostrando che essa è condizionata non solo da elementi o composti organici (ad esempio l’azoto, l’anidride carbonica) ma anche da composti inorganici (ad esempio i sali minerali), i primi potendo essere forniti dall’atmosfera (aria o pioggia) mentre i secondi possono derivare solo dalla decomposizione chimica del suolo. Nelle prime edizioni dell’opera precedente, Liebig ha stabilito due leggi fondamentali che regolano questa crescita. Una legge cosiddetta del minimo: un terreno deve contenere una quantità minima di tutti questi nutrienti, organici e inorganici, per essere fertile. E una legge cosiddetta della restituzione: è necessario, in un modo o nell’altro, restituire al suolo questi nutrienti, di cui la crescita delle piante tende a privarlo, in modo che rimanga fertile e i suoi rendimenti rimangano durevoli; altrimenti, il suo sfruttamento non può che essere predatorio, condannando il suolo alla morte (Saïto: 176-188).
Su questa base, nella quarta edizione del suo capolavoro (1842), quello su cui Marx aveva lavorato all’inizio degli anni cinquanta, Liebig lascia chiaramente intendere che l’agricoltura razionale, quella che rispetta alcuni principi – la pratica del maggese o della “rotazione”, con in particolare l’introduzione del trifoglio, l’uso di fertilizzanti naturali (cenere, ossa, escrementi animali) destinati a restituire al suolo i suoi nutrienti inorganici in attesa di eventuali fertilizzanti artificiali in grado di sostituirli, ecc. – è in grado di conservare intatta la fertilità del suolo, o addirittura di aumentarla. E se già accenna al fenomeno del calo delle rese agricole in Europa, è da imputare al mancato rispetto dei principi appena indicati (Saïto: 219-221).
In queste condizioni, la svolta che Liebig fece nella settima edizione di Die Chemie…, di cui Marx venne a conoscenza tra il 1863 e il 1865, è tanto più sorprendente. Questa svolta lo ha portato a formulare una sorta di terza legge, che potremmo chiamare legge del massimo in contrapposizione alla legge del minimo, che volta radicalmente le spalle al percorso da lui propugnato qualche anno prima. Egli spiega, in questo caso, che non si può aumentare indefinitamente la resa (la produttività) di un suolo in proporzione agli apporti supplementari di lavoro (drenaggio, arredo del suolo, irrigazione, ecc.), acqua, luce solare, calore, fertilizzanti, ecc., che possiamo assicurargli; che c’è un limite a questa crescita, semplicemente perché i nutrienti necessari di cui possiamo fornire un terreno (un determinato volume di esso) sono essi stessi in quantità limitata, ad esempio a causa dei limiti della sua disaggregazione chimica, e soprattutto perché le piante sono in grado di assorbire, attraverso le foglie o le radici, solo una quantità limitata di questi nutrienti in un dato tempo (per esempio, una stagione). Al di là di tale limite, ogni apporto supplementare potrà al massimo produrre dei risultati positivi temporanei, che andranno a scapito del successivo impoverimento del suolo, per il mancato rispetto della legge di restituzione (Saïto: 230-239).
«Con la preponderanza sempre crescente della popolazione urbana che esso stipa in grandi aggregati umani, [il modo di produzione capitalistico] da un lato accumula la forza di propulsione storica della società, dall’altro sconvolge il ricambio organico tra uomo e terra, cioè il ritorno al suolo dei suoi elementi costitutivi consumati dall’uomo sotto forma di mezzi di nutrizione e abbigliamento, e quindi la condizione naturale eterna di una sua fertilità duratura”. [11]
Di conseguenza, denuncia il modo in cui questa agricoltura, se inizialmente aumenta la produttività del lavoro agricolo, finisce per impoverire il suolo e comprometterne la fertilità, e quindi nuoce a questa stessa produttività:
“[…] ogni progresso dell’agricoltura capitalistica è un progresso non solo nell’arte di depredare l’operaio, ma anche nell’arte di depredare il suolo; ogni progresso nell’incremento della sua fertilità per un certo periodo, è insieme un progresso nella rovina delle sue sorgenti perenni. Quanto più un paese, come per esempio gli Stati Uniti d’America, parte dalla grande industria come base e sfondo del suo sviluppo storico, tanto più questo processo di distruzione è veloce». [12]
È quindi la stessa logica predatoria che governa sia lo sfruttamento della forza lavoro umana sia lo sfruttamento del suolo, e più in generale delle risorse naturali, queste due fonti di ogni ricchezza sociale, questi due fattori fondamentali del metabolismo tra umanità e natura:
“Perciò la produzione capitalistica sviluppa la tecnica e la combinazione del processo di produzione sociale solo minando al tempo stesso le fonti primigenie di ogni ricchezza: la terra e il lavoratore“. [13]
Marx quindi denuncia il fatto che il capitale mette in opera, nel suo rapporto con la terra, la stessa logica mortifera che aveva castigato, nel capitolo VIII di questo stesso libro, nel rapporto del capitale con la forza lavoro:
“La produzione capitalistica, che è essenzialmente produzione di plusvalore, estorsione di pluslavoro, produce quindi col prolungamento della giornata lavorativa non soltanto il deperimento della forza lavoro umana, che deruba delle sue condizioni normali, morali e fisiche, di sviluppo e d’autoesplicazione, ma il precoce esaurimento e la prematura estinzione della forza lavoro stessa: allunga per un certo periodo il tempo di produzione dell’operaio abbreviandone il tempo di vita”.[14]
Quanto poi alla terza legge di Liebig, essa convincerà Marx ad aderire alla tesi dei rendimenti agricoli decrescenti. Quest’ultima era stata formulata nella seconda metà del Settecento da vari autori sulla base dell’osservazione dell’evoluzione dell’agricoltura inglese, e ripresa in particolare da David Ricardo nell’ambito della sua teoria della rendita fondiaria sviluppata nei suoi Principi di economia politica e dell’imposta (1815). Secondo Ricardo, i rendimenti agricoli possono solo diminuire, di conseguenza aumentano i prezzi di mercato dei prodotti agricoli e, con essi, la rendita agricola, per due ragioni. Da un lato, perché man mano che l’agricoltura si sviluppa, per far fronte all’aumento della domanda (legato a quella della popolazione), i produttori agricoli sono costretti a ricorrere a terreni sempre meno fertili; dall’altro perché il rendimento dello stesso suolo non aumenta mai in proporzione diretta al capitale addizionale (e quindi in definitiva al lavoro morto e vivo) investito in esso per migliorarne la produttività.
Fino ai Manoscritti del 1861-1863 Marx si era mostrato molto riluttante, se non francamente ostile all’adozione della seconda parte di questa tesi (Saïto: 165-176). Ai suoi occhi, in mancanza di una base scientifica, era niente più un’ipotesi, tanto meno accettabile in quanto faceva il gioco della teoria della rendita fondiaria ricardiana e soprattutto di quella del suo nemico giurato, Thomas Malthus e della sua legge della popolazione. Questo è ciò che lascia chiaramente intendere in una lettera a Engels del 14 agosto 1851:
“Quanto più mi occupo di questo sudiciume, tanto più mi convinco che la riforma dell’agricoltura, e dunque anche questa merda della proprietà che si fonda su di essa, è l’alfa e l’omega della futura rivoluzione. Senza di questo, il padre Malthus ha ragione» (Saïto: 219).
In contrasto con la tesi dei rendimenti decrescenti, Marx ha poi espresso chiaramente la sua convinzione che una agricoltura razionale, basata sulla proprietà collettiva della terra e sull’applicazione metodica dei risultati delle scienze agrarie (raccomandando il drenaggio, l’aerazione e l’approvvigionamento del suolo, l’irrigazione, la rotazione delle colture, l’uso di fertilizzanti naturali o artificiali, ecc.), potrebbe far sperare in un costante miglioramento delle rese agricole, o addirittura in una crescita indefinita della produttività del lavoro agricolo simile a quella del lavoro manifatturiero. E aveva cercato e trovato elementi per alimentare la sua convinzione in vari autori, compreso lo stesso Liebig (Saïto: 209-224).
È la lettura della settima edizione del capolavoro di Liebig che lo convincerà a cambiare posizione, traendo in qualche modo le conseguenze dalla stessa svolta di Liebig. Marx può ora adottare la tesi dei rendimenti decrescenti, poiché questa può essere scientificamente fondata sulle leggi fisiologiche del regno vegetale, che né la meccanica né la chimica sono in grado di abolire o di superare. E quindi Marx potrà integrarla nella propria teoria della rendita fondiaria agricola, facendone la base della rendita differenziale II.
Più in generale e più radicalmente, la terza legge di Liebig convincerà Marx che esistono limiti assoluti alla modificazione antropologica (tecnica e scientifica) della natura da cui gli uomini non possono liberarsi. Ciò implica la rottura con ogni ingenuo prometeismo, ogni desiderio sconsiderato di dominare la natura, ogni culto della crescita cieca delle forze produttive sociali, ecc. Bisogna quindi rinunciare al progetto di un dominio totale e assoluto sulla natura, che può essere solo una illusione, per ridurlo a ciò che è compatibile con le leggi della natura e con i limiti che esse impongono alla umanità.
È quanto chiarisce Marx nel brano dei Manoscritti del 1863-1865, che Engels utilizzò per redigere la sua versione del Libro III del Capitale. Marx afferma risolutamente la necessità di un rapporto razionale tra società e natura a partire dalla dialettica tra necessità e libertà, rapporto che può realizzarsi solo nell’ambito di una società emancipata dai rapporti capitalistici di produzione:
“Come il selvaggio deve lottare con la natura per soddisfare i suoi bisogni, per conservare e riprodurre la sua vita, così deve fare l’uomo civile, e deve farlo in ogni forma di società e in tutti i modi di produzione possibili. Con il suo sviluppo si estende il regno della necessità naturale, perché si espandono i bisogni; ma nello stesso tempo si espandono le forze produttive si espandono che li soddisfano. La libertà in questo campo può consistere unicamente in ciò, che l’uomo socializzato, i produttori associati regolino razionalmente questo loro ricambio organico [metabolismo] con la natura, lo sottopongano al loro controllo collettivo, invece che esserne dominati come da una cieca potenza; lo eseguano col minor dispendio di energie e nelle condizioni più degne della loro natura umana e ad essa adeguate. Ma questo rimane pur sempre un regno della necessità. Al di là dei suoi confini ha inizio lo sviluppo delle capacità umane che è fine a se stesso; il vero regno della libertà che tuttavia può fiorire soltanto sulla base di quel regno della necessità. La riduzione della giornata lavorativa ne è la condizione fondamentale». [15]
Mentre in regime capitalista il metabolismo tra umanità e natura sfugge al controllo dei produttori (dei capitalisti come salariati) e li domina come una potenza straniera, alienata e alienante allo stesso tempo, poiché procede nonostante tutto dalle proprie attività produttive, il compito dei produttori associati che costituiscono una società comunista è di regolare consapevolmente e razionalmente il proprio metabolismo con la natura, il che implica in particolare di controllare il proprio rapporto con la natura in modo da renderlo compatibile con i limiti che gli impongono la Terra e la loro insuperabile dipendenza da essa. Nell’ordine del loro rapporto con la natura, l’unica libertà che gli uomini possono conquistare risiede in questo controllo razionale nonché nella riduzione del tempo di lavoro, resa possibile dal progresso della produttività del lavoro, di cui sarà diventata il fine prioritario. (Continua)
Note
[1] Cfr. ad esempio Alfred Schmidt, Il concetto di natura in Marx (a cura di R. Bellofiore), Ed. Punto rosso, Milano, 2018; Hans Immler, “Vergiss Marx, entdecke Schelling” in Hans Immler e Wolfdietrich Schmied-Kowarzig (sld), Marx und die Naturfrage, Kassel University Press, Kassel, 2011; Serge Audier, La société écologique et ses ennemis: pour une histoire alternative de l’émancipation, Paris, La Découverte, 2017.
[2] Questo orientamento include Paul Burkett, Marx and Nature: A Red and Green Perspective, 2a edizione, Haymarket Books, Chicago, 2014 (1a edizione 1999); John Bellamy Foster, Marx’s Ecology. Materialism and Nature, Monthly Review Press, New York, 2001; Henri Pena-Ruiz, Karl Marx: Penseur de l’écologie, Paris, Éditions du Seuil, 2018.
[3] Kohei Saito, La nature contre le capital. L’écologie de Marx dans sa critique inachevée du capital, tradotto dal tedesco da Gérard Billy, Syllepse-Page Deux, Paris, Lausanne, Montreal, 2021.
[4] MEGA: acronimo di Marx-Engels-Gesamtausgabe, Edizione Completa delle Opere di Marx ed Engels. Un primo tentativo di tale edizione, la MEGA 1, fu avviato nel 1927 da David Riazanov, direttore dell’Istituto Marx-Engels di Mosca, che, come lo stesso Riazanov, cadde vittima della dittatura stalinista venendo interrotto alla fine del 1930. Il progetto di una MEGA 2 è stato lanciato alla fine degli anni ’60 su iniziativa degli Istituti per il marxismo-leninismo con il Comitato Centrale del Partito Comunista dell’Unione Sovietica e il Comitato Centrale del Partito Socialista Unificato di Germania allora al potere nella Repubblica Democratica Tedesca (di solito denominata Germania dell’Est). Interrotto dalla “caduta del muro di Berlino” e dal crollo dell’URSS, il progetto è stato ripreso e portato avanti dal 1990 dall’Internationale Marx-Engels Stiftung (IMES: International Marx-Engels Foundation) con sede ad Amsterdam. La pubblicazione è suddivisa in quattro sezioni. La sezione I comprende tutti gli scritti conservati di Marx ed Engels, pubblicati o meno durante la loro vita, ad eccezione dei manoscritti e delle pubblicazioni che hanno preparato e accompagnato l’edizione del Capitale. Questo insieme di materiali è l’oggetto della sezione II. La sezione III è occupata dalla corrispondenza di Marx ed Engels, sia tra loro che con altri. Infine, una quarta sezione raccoglie tutti i quaderni e le note di lettura di Marx ed Engels, nonché le note a margine delle opere da loro lette e giunte fino a noi. L’insieme si comporrà di 115 volumi, alcuni dei quali suddivisi in più volumi. Da notare che in Francia è in corso di pubblicazione anche una Grande Edition Marx-Engels (GEME): https://geme.hypotheses.org/
[5] Manoscritti economico-filosofici del 1844, Einaudi, Torino, 1968, p. 77.
[6] Id., pagg. 78-79.
[7] Il brano in questione si trova alle pagg. 62 ss.
[8] Il termine è difficile da trasmettere in tutte le sue sfumature in francese. Bottigelli lo ha tradotto con sentimentale (pag. 51); Billy con calmo, pacifico, rilassato, familiare (Saïto: pagg. 33, 37, 40). A seconda del contesto, si potrebbe anche tradurlo con il termine paternalistico.
[9] Lineamenti fondamentali della critica dell’economia politica, La Nuova Italia, Firenze, 1968, vol. II, p. 114.
[10] A mio parere, Saïto commette un leggero errore nel collocare la stesura di questi manoscritti nel 1865-1866 (pag. 172). Infatti, in una lettera a Engels del 31 luglio, Marx confidava: “Per quanto riguarda il mio lavoro, ti dirò la schietta verità. Mancano da scrivere ancora tre capitoli per finire la parte teorica (i primi tre libri). Poi vi è ancora da scrivere il 4. libro, il lato storico-letterario, cosa che mi è relativamente più facile, dato che, essendo tutte le questioni risolte nei primi tre, quest’ultimo non è dunque più che una ripetizione in forma storica” (Marx-Engels, Carteggio, vol. IV, Editori Riuniti, Roma, 1971, p. 346). Si trattava dunque di scrivere una prima versione di tutto Il Capitale in quattro libri, come la concepì allora Marx. E, il 13 febbraio 1866, scrisse un’altra lettera a Engels annunciando il completamento di questo scritto: “Per quanto riguarda questo maledetto libro, le cose stanno così: era finito alla fine di dicembre. Soltanto la trattazione sulla rendita fondiaria, il penultimo capitolo, forma da solo, nella redazione odierna, un volume» (Id.: pag. 384). Nelle settimane successive, Marx passerà alla stesura della prima edizione tedesca del Libro I del Capitale, che sarebbe apparsa nell’autunno del 1867.
[11] Il Capitale, a cura di A. Macchioro e B. Maffi, Utet-De Agostini, Novara, Libro I, pag. 654.
[12] Id., pag. 655.
[13] Id., pagg. 655-6.
[14] Id., pag. 374.
[15] Il Capitale, cit., Libro III, pp. 1011-1012.
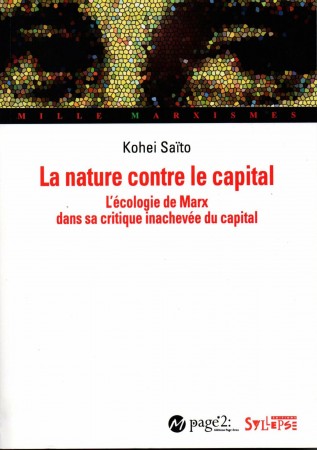

 Marx si approprierà largamente delle diverse leggi stabilite da Liebig, almeno inizialmente. Le prime due gli consentiranno di chiarire e approfondire la nozione di perturbazione metabolica che, a partire dai Manoscritti del 1844, caratterizza ai suoi occhi la produzione capitalistica. Nell’ultima sezione del capitolo XIII del libro I del Capitale, denuncia gli effetti sociali oltre che ecologici dell’introduzione del capitale nell’agricoltura. A cominciare dal fatto che rovinando i piccoli contadini e riducendo il numero (relativo) dei lavoratori agricoli, l’agricoltura capitalista spopola le campagne e ingrossa le città. In questo modo il capitale arriva a sconvolgere il metabolismo ancestrale esistente tra umanità e natura, che ha permesso alla prima di restituire alla seconda, sotto forma di residui (scarti delle sue attività) e rifiuti (i propri escrementi e quelli di bestiame e animali da tiro), ciò che aveva assunto come nutrimento attraverso la sua pratica agricola:
Marx si approprierà largamente delle diverse leggi stabilite da Liebig, almeno inizialmente. Le prime due gli consentiranno di chiarire e approfondire la nozione di perturbazione metabolica che, a partire dai Manoscritti del 1844, caratterizza ai suoi occhi la produzione capitalistica. Nell’ultima sezione del capitolo XIII del libro I del Capitale, denuncia gli effetti sociali oltre che ecologici dell’introduzione del capitale nell’agricoltura. A cominciare dal fatto che rovinando i piccoli contadini e riducendo il numero (relativo) dei lavoratori agricoli, l’agricoltura capitalista spopola le campagne e ingrossa le città. In questo modo il capitale arriva a sconvolgere il metabolismo ancestrale esistente tra umanità e natura, che ha permesso alla prima di restituire alla seconda, sotto forma di residui (scarti delle sue attività) e rifiuti (i propri escrementi e quelli di bestiame e animali da tiro), ciò che aveva assunto come nutrimento attraverso la sua pratica agricola: